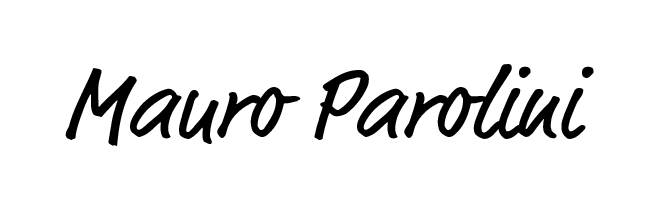Analogamente, ogni nostra mossa ha la sua partenza in questa esigenza di compimento che ci troviamo addosso. Secondo le parole di Tommaso dAquino, «tutti desiderano il raggiungimento della propria perfezione» (Summa Theologiae, I-II, 1, 7, c), cioè della propria felicità ultima, della propria realizzazione vera.
Proprio questo desiderio è allorigine delle vostre opere. Allora, per conservare la forza dellorigine occorre non perdere la potenza del desiderio da cui esse sono scaturite.
In questo senso, qual è il problema oggi? In tante occasioni, il desiderio viene ridotto a sentimento. Ma un desiderio ridotto a sentimento è un desiderio svuotato del suo essere. Che cosa sarebbe un desiderio a cui si è tolta la forza di perseguire ciò che si desidera? Unombra di desiderio. Un desiderio così ridotto non ha la forza di sostenere un impegno reale, una responsabilità, come spiega don Giussani: «Noi prendiamo il sentimento invece che il cuore come motore ultimo, come ragione ultima del nostro agire. Cosa vuol dire? La nostra responsabilità è resa vana proprio dal cedere alluso del sentimento come prevalente sul cuore, riducendo così il concetto di cuore a quello di sentimento. Invece, il cuore rappresenta e agisce come il fattore fondamentale dellumana personalità; il sentimento no, perché preso da solo il sentimento agisce come reattività, in fondo è animalesco. Non ho ancora compreso – dice Pavese – quale sia il tragico dellesistenza […]. Eppure è chiaro: bisogna vincere labbandono voluttuoso e smettere di considerare gli stati danimo quali scopo a se stessi. Lo stato danimo ha ben altro scopo per essere dignitoso: ha lo scopo di una condizione messa da Dio, dal Creatore, attraverso la quale si è purificati. Mentre il cuore indica lunità di sentimento e ragione. Esso implica una concezione di ragione non bloccata, una ragione secondo tutta lampiezza della sua possibilità: la ragione non può agire senza quella che si chiama affezione. È il cuore – come ragione e affettività – la condizione dellattuarsi sano della ragione. La condizione perché la ragione sia ragione è che laffettività la investa e così muova tutto luomo. Ragione e sentimento, ragione e affezione: questo è il cuore delluomo» (L. Giussani, Luomo e il suo destino, Marietti, Genova 1999, pp. 116-117).
Quando questo svuotamento del desiderio si compie, allora non cè altra strada per lazione che il moralismo. Unazione diventa moralistica quando perde il nesso con ciò che la genera: continuare a vivere da sposati senza il nesso con lattrattiva che ha generato il rapporto amoroso, lavorare senza nesso con il desiderio di compimento anche se con un buono stipendio. Insomma: quando accade questo restano soltanto le regole da rispettare. Tutto diventa pesante, uno sforzo titanico per fare qualcosa che non centra più niente con il nostro desiderio.
Tutti sappiamo quanto arduo risulta tenere desto il desiderio. Allora la tentazione più ovvia è passarci sopra e chiudere la partita. Quanti di voi avete sentito questa tentazione quando il desiderio è venuto meno davanti alle enormi difficoltà che vi trovate ad affrontare in questi tempi di crisi!
Dunque la questione da affrontare è semplice: è possibile tenere desto il desiderio davanti alle sfide del presente?
Nel bambino possiamo rintracciare tutta quanta lapertura totale del desiderio. La sorprendiamo in quel fenomeno così umano della curiosità, che lo rende cordialmente aperto a tutto: «Il cuore di un bambino è fatto per scoprire, per starci a godere, per viaggiare per tutto luniverso senza posa, mai stanco e sempre lieto, in pace, curioso e soddisfatto» (L. Giussani, Realtà e giovinezza. La sfida, SEI, Torino 1995, pp. 78-79).
Ma vediamo che, strada facendo, questa apertura piena di curiosità può decadere fino quasi al punto di sparire, come documenta lo scetticismo di tanti adulti. Infatti tutto limpeto con cui un bambino esce dal seno di sua madre non può evitare il suo decadere fino alla morte.
Possiamo vedere la stessa parabola nella vita adulta, nel lavoro, nelle opere. Tutto limpeto con cui uno incomincia a lavorare non può impedire che pian piano venga meno, e nemmeno che uno possa diventare stufo di esso.
Allora qui abbiamo davanti a noi la vera sfida: è possibile mantenere la forza propulsiva dellorigine? Lesempio del bambino ci mette davanti agli occhi che tutta la sua energia non è sufficiente per mantenere vivo il desiderio in tutta la sua ampiezza. Luomo è incapace di tenere fresca, viva lorigine da solo, come dice ancora don Giussani: «Mantenere nella vita loriginale simpatia allessere o al reale con cui nasciamo, essere nella vita veramente come bambini (o poveri di spirito, direbbe il vangelo), perché questa positività continua di fronte al reale non è che lessere bambini, è la posizione del bambino: di essere così nella vita noi riconosciamo di essere incapaci; perciò ci vuole qualcosa daltro» (L. Giussani, Lautocoscienza del cosmo, Bur, Milano 2000, p. 306).
Si capisce dunque come la presunzione moderna acquisti la faccia del moralismo: «Il distacco del senso della vita dallesperienza implica anche un distacco della moralità dallazione delluomo: la moralità, così concepita, non ha la stessa radice dellazione. In che senso? Nel senso che la morale centra sì con lazione delluomo, centra con lesperienza, ma senza avere la stessa radice dellazione; non risponde alla fisionomia, al volto che ci dà lesperienza. Così, tra laltro, si comprende lemergere del moralismo: è la moralità che, paradossalmente, non centra con lazione, nel senso che non nasce contemporaneamente ad essa. Il moralismo è un insieme di principi che precede e investe lazione delluomo giudicandola teoricamente, astrattamente, senza motivare il perché sia giusto o no, il perché luomo debba compiere o non debba compiere unazione. Definendo a priori lazione che luomo sta compiendo, si giudica quello che luomo fa, senza che lui ne abbia avuto consapevolezza, o senza che lui abbia concepito il suo fare nel mondo e il suo camminare nelle vie del tempo e dello spazio come praticabili. La moralità così non ha la stessa radice dellazione. Per cui essa finisce col sottolineare valori comuni, valori generalmente sentiti; i suoi principi sono perciò o derivati dalla mentalità comune o imposti dallo Stato» (L. Giussani, Luomo e il suo destino, op. cit., p. 106).
È il trionfo del volontarismo più sterile: «Di fronte allimpossibilità di realizzare una umana immagine, di fronte ad una natura materialisticamente intesa che tutto travolge ed elimina, la forza dellumana volontà si prefigge in modo ferreo un progetto e con tutta la sua energia cerca di realizzarlo. Riporto a titolo di esempio questo brano di Russell: …Provai qualcosa come quello che il popolo religioso chiama conversione. Diventai improvvisamente e vividamente consapevole della solitudine in cui i più vivono e appassionatamente desideroso di trovare delle vie per diminuire questo tragico isolamento. La vita delluomo è una lunga marcia attraverso la notte circondato da nemici invisibili, torturato da logoramento e pena; ad uno ad uno come in un libro i nostri compagni di viaggio svaniscono alla nostra vista; brevissimo è il tempo in cui possiamo aiutarli. Versi il nostro tempo luce solare sul loro sentiero, per rinnovare il coraggio che vien meno, per istillare fede nelle ore di disperazione. Coraggio: perché? Fede: quale? Il volontarismo mostra la sua cecità e la sua irrazionalità. Con esso luomo cerca di estendere le sue capacità ad un orizzonte che la sua coscienza più riflessa sa di non poter raggiungere, come la rana della favola che gonfiò se stessa, ma ad un certo punto non poté che scoppiare» (L. Giussani, Il senso di Dio e luomo moderno, Bur, Milano 1994, pp. 111-112).
Se non siamo in grado di tenere vivo il desiderio, il moralismo ci costringe a fare le cose anche quando quel desiderio è finito. Tutti possiamo immaginare che cosa è la vita o il lavoro quando viene ridotto a puro dovere. Il logoramento delle persone, la stanchezza cronica, lassenza di un motivo adeguato per lazione sono la minaccia più grande della responsabilità. Le conseguenze sono in agguato. Lunica incognita è quanto tempo occorrerà per darsi alla fuga.
È possibile continuare nella vita adulta la propria attività senza essere condannati a fuggire prima o poi? Sì, però solo se viene costantemente ridestato il desiderio. E questo non possiamo farlo da soli, lo sappiamo per esperienza. È quello che è venuto a fare Cristo. Lincontro con Cristo produce la sorpresa del ridestarsi in noi del desiderio: un incontro è la grande e unica risorsa per una ripresa del nostro io. Ma qual è la portata di questo avvenimento nella vita della persona? «È un incontro ciò che suscita la personalità, la coscienza della propria persona. Lincontro non genera la persona (la persona è generata da Dio quando ci dà la vita attraverso padre e madre); ma è in un incontro che io maccorgo di me stesso, che la parola io o la parola persona si desta. […] Lio si desta dalla sua prigionia nella sua vulva originale, si desta dalla sua tomba, dal suo sepolcro, dalla sua situazione chiusa dellorigine e – come dire – risorge, prende coscienza di sé, proprio in un incontro. Lesito di un incontro è la suscitazione del senso della persona. È come se la persona nascesse: non nasce lì, ma nellincontro prende coscienza di sé, perciò nasce come personalità». Questo incontro che ridesta la persona rappresenta linizio dellavventura – qui vediamo in azione tutto il genio educativo di don Giussani -, esso non è la fine di un percorso o la meta del cammino, ma il principio di una storia destinata a investire tutta la realtà. Giussani ci rende consapevoli anche di quali sono le conseguenze negative che comporta il trattare lincontro come un punto di arrivo: «Il problema incomincia qui, a questo punto, quando la persona è destata: tutta lavventura incomincia qui, non termina qui. Perché per molti Cl diventa una delusione? Perché una volta che sono entrati è come se avessero chiuso, è come se fossero arrivati». Al contrario, lincontro costituisce linizio di tutto: «Lavventura incomincia quando la persona è destata dallincontro […]. E lavventura è lo sviluppo drammatico del rapporto tra la persona risvegliata e la realtà intera da cui essa è circondata e in cui vive» (L. Giussani, Lio rinasce in un incontro (1986-1987), Bur, Milano 2010, pp. 206-207).
Perciò la vera questione è che questo inizio permanga contemporaneo. Cristo è contemporaneo a noi nel carisma. Nellincontro con il carisma di don Giussani si è ridestato il nostro io. E tante opere tra di noi sono frutto di questo io ridestato dal carisma. Possiamo mantenere la forza dellorigine, se rimaniamo collegati al carisma, così come don Giussani vi diceva nella vostra Assemblea Nazionale del 1995: «Quanto più uno ama la perfezione nella realtà delle cose, quanto più ama le persone per cui fa le cose, quanto più ama la società per cui fa la sua impresa, di qualunque genere, tanto più è per lui desiderabile essere perfezionato dalla correzione. È questa la povertà del nostro possedere le cose, che in ogni lavoro, in ogni impresa rende luomo attore, artefice, protagonista. Ma libertà vuol dire anche, oltre che coscienza del proprio limite, impeto creatore. Se è rapporto con lInfinito, essa mutua dallInfinito questa inesausta volontà di creare. Non è così soltanto per chi è tanto vecchio da essere già morto – e questo può capitare a ventanni! Quanti se ne vedono, a ventanni, senza più desideri, senza più fantasia, senza più tentativo, senza più rischio nella vita! Tutto è correggibile e tutto deve essere creabile. Questo istinto creatore è ciò che qualifica la libertà in un modo più positivo e sperimentalmente affascinante» (L. Giussani, Lio, il potere, le opere, Marietti, Genova 2000, p. 117).
Ecco perché la Compagnia delle Opere è diversa da qualsiasi altra associazione, con una sua propria originalità: destare e sostenere le energie del singolo. Solo da qui è possibile una risposta alle sfide di oggi. Cito questo bellissimo passaggio di don Giussani dalla vostra Assemblea Nazionale del 1993: «La vostra compagnia è tesa a creare una casa più abitabile per luomo. E ci riesce, poco o tanto non importa, ma ci riesce. Ognuno di voi lha sperimentato. Perché la vostra compagnia è tesa a creare una casa abitabile per luomo? Perché la vostra passione è luomo nella sua concretezza evidente. Vale a dire: luomo che è nel bisogno. È nel bisogno, infatti, che luomo è e si ritrova veramente se stesso. E il bisogno è oggi. Pensare di risolvere un bisogno domani o tra un anno è altamente equivoco se non colloca subito i fattori in modo più propizio per rispondere alla fame e alla sete, alla necessità che luomo vive adesso. Domandiamoci perché Gesù suscitava tanta curiosità e stupore in chi Lo incontrava. Perché era un uomo nel quale chiunque lo vedeva agire e lo sentiva parlare, percepiva una cosa, soprattutto una cosa: non la Trinità, lInferno o il Paradiso, ma una passione per luomo, innanzitutto una passione per il bisogno delluomo. Una pietà per luomo: Volse lo sguardo e vide tutta quella folla ed ebbe pietà di loro, perché erano come un gregge senza pastore. Per questo la gente Lo seguiva» (Ibidem, p. 131).
Questo sguardo dellaltro mondo in questo mondo genera tra di noi una nuova responsabilità (non la vecchia responsabilità secondo gli schemi del mondo, che cerca nellopera e nel profitto il proprio compimento, una volta ridotto il desiderio). Questo sguardo ci dà un volto nuovo col quale presentarci di fronte ai fratelli uomini, ed è lunica cosa che potrà dare un contributo reale alla società contemporanea.
E questo sguardo, portato sugli altri perché riconosciuto anzitutto su di noi, è ciò che mi auguro e ciò che vi auguro.
Grazie.